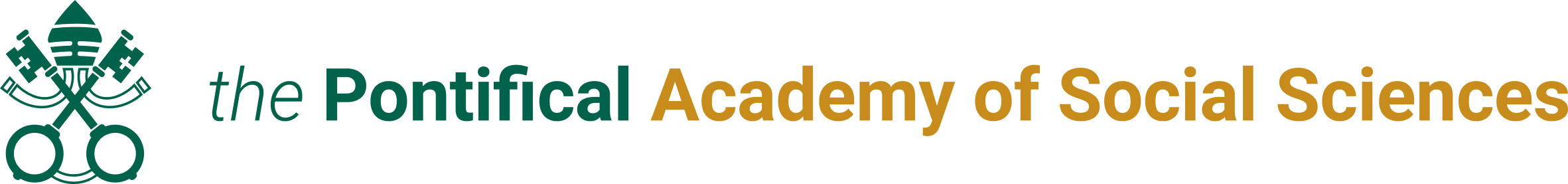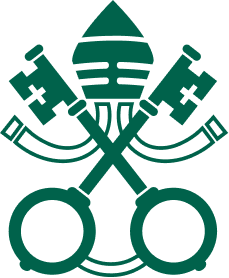La XV Sessione Plenaria della Pontifica Accademia delle Scienze Sociali ha discusso il tema: “Dottrina Sociale Cattolica e Diritti Umani”, ad un anno di distanza dal 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Queste le principali conclusioni:
1. La pietra miliare della Dichiarazione universale
Nell’età contemporanea la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, considerata da Paolo VI uno dei maggiori titoli di gloria delle Nazioni unite, è stata fondamentale per il consolidamento nella coscienza collettiva del rispetto dei diritti e per integrare in ulteriori Dichiarazioni la grandezza e la dignità della persona umana. In questo processo ha influito positivamente la dottrina sociale cattolica sui diritti umani, risultata operante anche in culture e tradizioni non occidentali. In specie a partire dalla Pacem in terris, la Chiesa cattolica ha offerto crescente appoggio alla Dichiarazione universale.
2. Le basi antropologiche dei diritti umani. Diritti e doveri
In questo quadro in movimento, in cui l’agenda dei diritti umani volge anche verso l’introduzione di “nuovi diritti”, è importante sviluppare le basi antropologiche e morali dei diritti che la Dichiarazione proclama. In effetti la cultura contemporanea è erede di una visione antropocentrica del mondo in cui l’individuo è fonte del bene e del male, mentre il “contratto sociale” è un accordo mutevole delle volontà. A questa visione risponde l’antropologia realistica aristotelico-tomista assunta dalla dottrina sociale della Chiesa. Essa vede la persona umana inserita in una relazione costitutiva con gli altri e con il creato, cioè in un ordine – chiamato legge naturale – che la ragione deve mettere in luce. Attualmente la solidità di questa antropologia viene sfidata da antropologie secolari a sfondo evoluzionistico e costruttivistico. Esse rifiutano l’idea di una natura umana comune, e ritengono che l’essere umano sia una costruzione sociale in cui emergono la storicità
... Read allLa XV Sessione Plenaria della Pontifica Accademia delle Scienze Sociali ha discusso il tema: “Dottrina Sociale Cattolica e Diritti Umani”, ad un anno di distanza dal 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Queste le principali conclusioni:
1. La pietra miliare della Dichiarazione universale
Nell’età contemporanea la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, considerata da Paolo VI uno dei maggiori titoli di gloria delle Nazioni unite, è stata fondamentale per il consolidamento nella coscienza collettiva del rispetto dei diritti e per integrare in ulteriori Dichiarazioni la grandezza e la dignità della persona umana. In questo processo ha influito positivamente la dottrina sociale cattolica sui diritti umani, risultata operante anche in culture e tradizioni non occidentali. In specie a partire dalla Pacem in terris, la Chiesa cattolica ha offerto crescente appoggio alla Dichiarazione universale.
2. Le basi antropologiche dei diritti umani. Diritti e doveri
In questo quadro in movimento, in cui l’agenda dei diritti umani volge anche verso l’introduzione di “nuovi diritti”, è importante sviluppare le basi antropologiche e morali dei diritti che la Dichiarazione proclama. In effetti la cultura contemporanea è erede di una visione antropocentrica del mondo in cui l’individuo è fonte del bene e del male, mentre il “contratto sociale” è un accordo mutevole delle volontà. A questa visione risponde l’antropologia realistica aristotelico-tomista assunta dalla dottrina sociale della Chiesa. Essa vede la persona umana inserita in una relazione costitutiva con gli altri e con il creato, cioè in un ordine – chiamato legge naturale – che la ragione deve mettere in luce. Attualmente la solidità di questa antropologia viene sfidata da antropologie secolari a sfondo evoluzionistico e costruttivistico. Esse rifiutano l’idea di una natura umana comune, e ritengono che l’essere umano sia una costruzione sociale in cui emergono la storicità delle culture, la relatività delle norme morali, la centralità delle sole scelte individuali. Nel caso della famiglia e della procreazione ciò implica che maternità e paternità siano realtà costruite socialmente, che possono ad ogni momento essere liberamente ridefinite.
Si è arrivati ad un certo abuso della nozione di diritto, inteso in senso molto elastico. Il diritto non è però frutto di un desiderio o di una passione, ma la misura giusta di ciò che è dovuto alla persona nel suo rapporto con gli altri o con le istituzioni. Questa misura è giusta non per decisione arbitraria, ma perché scaturisce dall’ordine naturale delle cose.
La ricerca sulle basi antropologiche della Dichiarazione universale spinge anche a riconsiderare la relazione inscindibile tra diritti e doveri e la necessità di una nuova stagione dei doveri, in specie in talune aree geopolitiche e culturali in cui vengono richiesti sempre nuovi diritti, di cui non si pone in luce la giustificazione né il loro nesso coi doveri. Non pochi aspetti dell’eccezionale crisi economica che si è abbattuta sul pianeta possono essere ricondotti ad una estesa sconnessione tra diritti e doveri e alla violazione di giustizia ed equità. È assunto centrale del Magistero cattolico che i diritti umani sono svuotati quando si rescinde il loro legame coi doveri. I diritti alla vita, alla famiglia, al cibo si traducono in veri doveri per gli altri e la società di proteggere la vita, di favorire la costituzione delle famiglie, di organizzare la società in tal modo che ognuno possa assicurare la propria sussistenza mediante il suo lavoro.
3. I diritti umani: universali, indivisibili, interconnessi
I diritti umani sono inerenti alla natura dell’uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio. Anche se la loro elaborazione è in gran parte frutto della cultura giuridica occidentale, essi rispondono alla natura di ogni uomo ed in virtù di ciò sono universali. Essi sono stati ratificati da quasi tutti gli Stati del mondo, rappresentando perciò un ethos universale condiviso.
La Dichiarazione non è però una lista di diritti da cui ciascuno sceglie secondo gli interessi e le opportunità pragmatiche del momento uno o più diritti da potenziare e rielaborare. I diritti elencati nella Dichiarazione risultano universali, indivisibili ed interconnessi, di modo che nessuno può essere lasciato da parte.
4. Universalità sincronica e diacronica dei Diritti Umani
Come è stato detto nel corso della Sessione, si può parlare di universalità “orizzontale o sincronica”. In tutte le regioni del pianeta vanno pertanto garantiti il diritto alla vita, alla famiglia, alla libertà religiosa, al cibo, dei quali la Sessione ha fatto specifico approfondimento.
Pace, ambiente e sviluppo – usualmente catalogati come diritti della terza generazione – sono la base per consentire alle generazioni future di godere dei diritti di prima generazione (civili e politici) e di seconda generazione (economico-sociali). Da questo punto di vista si può parlare di “universalità verticale o diacronica”, nel senso che la loro attuazione consente di garantire i diritti umani non solo alle presenti ma anche alle future generazioni.
I diritti umani di terza generazione non sono “giustiziabili” e rispondono piuttosto a nobili aspirazioni dell’umanità, da non confondere con la categoria del diritto in senso proprio.
Cionondimeno anche essi hanno bisogno di una solida base etica e politica.
5. Dialogo tra le religioni e tra le scienze
Il dialogo inter-culturale e quello inter-religioso rappresentano uno strumento importante per consolidare l’universalità dei diritti umani e realizzarli tenendo sempre a stella polare la loro interdipendenza ed indivisibilità.
Il dialogo inter-religioso aiuta l’impegno comune in favore della giustizia e della pace e mostra come tutte le confessioni religiose possono aspirare al bene dell’uomo.
Anche il dialogo tra i saperi è utile al bene comune. Lo è oggi, in particolare, il dialogo tra il sapere delle scienze ed il sapere della teologia. Il progresso scientifico dimostra, infatti, sempre più frequentemente come la Verità della fede non configge affatto con la verità scientifica. Ordine naturale e scienza non sono in contrasto tra loro. Un esempio per tutti relativo al primo dei diritti umani, il diritto alla vita: che l’embrione sia vita umana personale non è solo un’ affermazione della Chiesa cattolica, è anche il frutto della migliore ricerca scientifica odierna. Pur non essendo in senso proprio verità di fede, ha sottolineato Benedetto XVI, i Diritti Umani acquistano piena luce e trovano conferma dalla fede.
6. Diritti umani e sviluppo economico
Gli studi dimostrano come a medio termine un assetto democratico di governo ed il rispetto dei diritti umani incide positivamente sullo sviluppo economico di un paese. C’è da domandarsi, peraltro, se sia vero anche il contrario: cioè se lo sviluppo economico di un paese porti sempre con sé più democrazia e più diritti umani.
I casi della Cina e dell’India, oggetto di speciale riflessione, sono una cartina di tornasole.
7. Crisi dei Diritti Umani, crisi della democrazia, crisi del capitalismo
I fattori che hanno prodotto la crisi dei Diritti Umani sono molteplici.
Da un punto di vista fenomenologico, nonostante le numerose riaffermazioni di essi nelle carte internazionali, i Diritti Umani sono diffusamente violati in numerosi paesi di tutte le regioni del mondo, anche in quelli retti da regimi democratici. Ad esempio la libertà religiosa per la Dottrina Sociale Cattolica è al centro dei diritti scaturenti dalla natura umana ed è ormai considerata diritto umano da carte e documenti internazionali in tutti i suoi aspetti (individuale, collettivo ed istituzionale). Ma essa continua ad essere negata in vari Stati (all’inizio di aprile è stato arrestato un Vescovo in Cina) e continuano le discriminazioni contro i credenti, particolarmente nei Paesi a tradizione non cristiana e con la novità, quanto ai Paesi a radice cristiana, che oggi ad essere discriminati sono coloro che appartengono alla maggioranza religiosa (ad esempio in Spagna).
Ma vi è una crisi più profonda. Essa è, anzitutto, dovuta allo scollegamento dei Diritti Umani dall’ordine naturale. Non solo viene esasperato il loro carattere soggettivo ed individualista, ma semplici desideri vengono eretti a diritto.
In secondo luogo è in crisi l’effettiva e concreta capacità della comunità internazionale di garantirne l’osservanza. All’attribuzione uguale dei diritti continua pertanto a corrispondere l’acceso diseguale ai mezzi per ottenerla.
La proliferazione di documenti ed organismi internazionali (agenzie, organizzazioni, relatori speciali...) non è sempre purtroppo andata a vantaggio della più sollecita tutela. Un esempio relativo al diritto al cibo: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 lo considera diritto umano, ma si deve attendere il 1996 per trovare il World Food Summit ed il 2004 per le Linee Guida. Anche in questo campo arrivare tardi significa negare il diritto. Come ha sottolineato S.S. Benedetto XVI, nel discorso che ci ha rivolto, il fatto che ancora oggi un quinto dell’umanità soffre la fame “è una tragedia vergognosa”, che implica responsabilità internazionali; come lo è il problema dell’acqua e dell’energia.
8. La risposta alla crisi
Va crescendo la consapevolezza che per rispondere alla crisi è necessaria una risposta globale che deve trovare il maggior consenso e la maggior condivisione possibili.
Da questo punto di vista il ruolo centrale assunto dal G20 piuttosto che dal G8 è un segnale positivo, ma si devono trovare mezzi e strumenti per garantire una giusta rappresentanza delle ragioni dei paesi meno sviluppati.
La tutela dei più deboli, d’altro canto, non può certamente essere lasciata solamente al movimento no-global, spontaneismo fortemente ideologizzato.
Rispettare il diritto naturale e promuovere la solidarietà e la sussidiarietà con le regioni e le popolazioni più povere, così da eliminare le ineguaglianze sociali, è un impegno per tutti, per coloro che hanno responsabilità decisionali a livello internazionale o nazionale, non meno che per gli attori privati.
9. Etica e politica: democrazia e capitale
Soprattutto è oggi necessario un ritorno al primato dell’etica sulla politica e della politica sulla tecnica.
La politica come forma più alta di carità cristiana (Paolo VI) richiede il rispetto dell’etica della responsabilità. Essa è lo strumento con cui l’etica può essere reintrodotta nel sistema.
Il solo diritto o la sola economia, senza il controllo e la guida della politica, corrono il rischio di tradursi in un tecnicismo che, lungi dal garantire il bene comune, tendenzialmente fa diventare ricchi i più ricchi e poveri i più poveri. Ne è esempio l’attuale crisi finanziaria: strumenti molto sofisticati da un punto di vista giuridico ed economico sono stati impiegati a danno degli anelli più deboli della catena sociale. Anche le imprese (specie le multinazionali) devono essere sollecitate (norme inter-nazionali, leggi statali, campagne di opinione pubblica), dalle Organizzazioni Internazionali, Stati e ONG (cioè da tutti i decisori politici), ad interrogarsi sul ruolo che esse hanno nell’assicurare i Diritti Umani. Già alcune di esse si impegnano in tal senso. L’approccio deve essere globale: l’intera attività deve essere ispirata eticamente e in ogni parte del mondo rispettare tali criteri.
La bolla finanziaria che sta producendo conseguenze devastanti, benché abbia avuto alle sue spalle leggi che l’hanno consentita, assume ormai e sempre più aspetti analoghi a quelli caratterizzanti i crimini contro l’umanità. Il principio di tassatività della fattispecie impedisce di sottoporre la questione a corti internazionali, le quali peraltro arriverebbero ben tardi rispetto alle reali necessità. Ma occorre comunque che tutti prendano consapevolezza della gravità etica sottostante alla odierna crisi finanziaria. Occorre inoltre anche in questo campo riaffermare il primato della politica sulla tecnica all’interno del concerto internazionale, e il rilievo dei diritti economici e sociali, in rapporto ai quali sta accadendo una destatualizzazione degli ordinamenti giuslavoristici e un abbassamento degli standards sociali di protezione e implementazione.
10. Globalizzazione della solidarietà e responsabilità di proteggere
La legge naturale, iscritta nel cuore di ogni essere umano, impone a tutti, a cominciare dalle Organizzazioni Internazionali, di promuovere la globalizzazione della solidarietà perché le zone più fragili del pianeta siano aiutate, la vita umana tutelata, la libertà religiosa promossa, la famiglia incoraggiata, l’ambiente rispettato. In questo scenario la “responsabilità di proteggere l’uomo” di cui ha parlato Benedetto XVI all’Assemblea Generale dell’ONU riguarda tutti i Diritti Umani. Nessuno di essi deve essere piegato ad interessi particolari, non rispettosi dell’unità della persona umana e dell’indivisibilità dei suoi diritti.
Opporre le armi alla mano dell’aggressore è possibile, purché sia il rimedio ultimo al fallimento di ogni possibile via diplomatica. Viene qui realizzata la responsabilità di proteggere popolazioni o gruppi etnici minacciati di genocidio o sterminio, e di sanare situazioni di grave emergenza umanitaria.
Nel promuovere la globalizzazione della solidarietà come nell’esercitare la responsabilità di proteggere la speranza cristiana sia la stella polare.
11. Implementazione e monitoraggio dei diritti umani
È stata sottolineata l’importanza di monitorare le violazioni dei diritti umani attraverso agenzie internazionali capaci di porre in atto azioni di correzione e di ristabilimento dei diritti violati (compliance), facendo perno su tutte le risorse disponibili e sull’evoluzione contemporanea verso un diritto internazionale dei diritti umani, basato sull’assioma dignitas humana servanda est.
Ombretta Fumagalli Carulli
Roland Minnerath
Vittorio Possenti